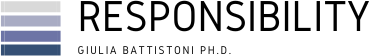Giulia Battistoni, SAFI President (Marie Skłodowska-Curie Global Fellow, University of Verona)
Questa è la seconda parte di una serie di due articoli sul blog. Leggi la prima parte qui.
La Proposta di Ferrajoli
A partire da questo solido quadro teorico, Ferrajoli presenta il Progetto di Costituzione della Terra, articolato in 100 articoli suddivisi in due parti principali:
Parte I: Principi Fondamentali. Questa sezione definisce gli obiettivi e la finalità della Costituzione:
- Titolo I: Principi Supremi – Stabilisce gli obiettivi principali della Federazione della Terra, tra cui la pace, la tutela dell’ambiente, la salvaguardia delle risorse vitali, il divieto di beni distruttivi e la garanzia dei diritti fondamentali e dell’uguaglianza di fronte alla legge.
- Titolo II: Diritti Fondamentali – Riconosce i diritti umani già sanciti dalle principali dichiarazioni internazionali, spesso violati sotto regimi autoritari.
- Titolo III: Beni Fondamentali – Introduce un’innovazione significativa, creando un sistema globale di beni comuni per la protezione dell’aria, dell’acqua pulita e delle foreste, garantendo al contempo l’accesso universale a beni essenziali come i farmaci salvavita. Include, inoltre, la tutela dell’integrità personale, come la protezione del corpo umano.
- Titolo IV: Beni Illeciti – Proibisce la produzione, il commercio e il possesso di beni dannosi, come le armi e altri materiali distruttivi.
Parte II: Istituzioni e strumenti. Questa sezione definisce le istituzioni incaricate di garantire l’applicazione degli obiettivi della Costituzione:
- Titolo I: Federazione della Terra – Delinea il ruolo e le funzioni della Federazione, fornendo un quadro per la governance globale.
- Titolo II: Istituzioni e Funzioni Globali di Governo – Amplia il mandato delle istituzioni esistenti dell’ONU, come l’Assemblea Generale, il Consiglio di Sicurezza e il Consiglio Economico e Sociale, sottolineando che i governi nazionali devono mantenere il controllo sulla governance interna.
- Titolo III: Istituzioni e Funzioni Globali di Garanzia Primaria e Secondaria – Definisce due livelli di garanzie:
- Garanzie Primarie – Mira a rafforzare istituzioni come l’OMS, la FAO e l’UNESCO, introducendo al contempo nuovi organi, tra cui un Consiglio Internazionale dei Diritti Umani. Propone, inoltre, lo scioglimento degli eserciti nazionali e la creazione di un sistema globale di beni comuni per la tutela ambientale.
- Garanzie Secondarie – Prevede l’espansione della giurisdizione della Corte Internazionale di Giustizia e della Corte Penale Internazionale per includere le violazioni delle libertà da parte di regimi dispotici e atti di violenza contro i diritti fondamentali. Introduce inoltre due nuove corti: una Corte Costituzionale Globale e un Tribunale Internazionale per i Crimini di Sistema, incaricati di indagare sulle violazioni su larga scala.
- Titolo IV: Istituzioni Economiche e Finanziarie – Propone la riforma degli organismi finanziari globali, come la Banca Mondiale e il FMI, e la creazione di un bilancio globale e di un sistema di tassazione volto a redistribuire la ricchezza, proteggere l’ambiente e trasferire il debito delle nazioni più povere alla Federazione della Terra come compensazione per lo sfruttamento storico da parte dei paesi più ricchi.
Sfide e Questioni Aperte
La Costituzione della Terra proposta da Ferrajoli rappresenta un ambizioso e articolato quadro teorico per la giustizia globale, offrendo un contributo significativo al dibattito sul diritto internazionale. Tuttavia, la sua attuazione si scontra con sfide pratiche di rilievo che potrebbero comprometterne la realizzabilità. Nella parte finale di questo articolo, pur riconoscendo i punti di forza e la rilevanza della proposta, analizzerò criticamente gli ostacoli che potrebbero emergere nella pratica. Il mio obiettivo è accrescere la consapevolezza pubblica e stimolare una riflessione più approfondita tra gli esperti, incoraggiando la ricerca di soluzioni pratiche per tradurre questa visione ambiziosa in realtà.
- Definire i Crimini di Sistema e la Responsabilità per un Quadro di Giustizia Globale Più Solido – Il concetto di crimini di sistema, elaborato da Ferrajoli, rischia di rimanere vago a causa della natura indeterminata delle azioni qui considerate, delle loro conseguenze e della dimensione collettiva sia degli autori che delle vittime.[3] Inoltre, ritengo fondamentale una revisione parallela e un rafforzamento del concetto di responsabilità e dei suoi criteri applicativi in questi casi, altrimenti l’effettiva implementazione delle norme risulterebbe pressoché impossibile.[4] Oltre a riconoscere i limiti del diritto penale, come fa Ferrajoli, occorrerebbe anche esplorarne le potenzialità. La criminalizzazione del danno ambientale e l’introduzione di pene severe potrebbero fungere da forte deterrente. Un progresso significativo in questa direzione è rappresentato dalla Direttiva europea sui crimini ambientali del 2024, che introduce i cosiddetti “reati qualificati”, come gli incendi boschivi su larga scala o l’inquinamento grave, punibili con pene fino a 10 anni di carcere e applicabili in tutta l’UE entro il 2026.[5] Parallelamente, proseguono gli sforzi per riconoscere l’ecocidio come crimine internazionale nell’ambito dello Statuto di Roma, portandolo sotto la giurisdizione della Corte Penale Internazionale.
- La Dialettica Irrisolta tra Giurisdizione Sovranazionale e Sovranità Nazionali – Ferrajoli immagina una federazione globale capace di superare la sovranità nazionale, ma la storia dimostra quanto tali trasformazioni incontrino forti resistenze. Persino in Europa, il cammino verso l’unità è stato segnato da tensioni e battute d’arresto. Il principale ostacolo? Le élite politiche, economiche e finanziarie, che potrebbero rifiutarsi di sottomettersi al diritto internazionale. Esempi concreti dimostrano questa complessità. Il 9 aprile 2024 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) ha emesso una sentenza storica, condannando la Svizzera per inazione climatica in seguito al ricorso di un gruppo di donne anziane (Verein KlimaSeniorinnen). Tuttavia, poco dopo, la commissione giuridica del Senato svizzero ha respinto il verdetto, appellandosi ai principi democratici: gli elettori svizzeri avevano già rifiutato una legge climatica più rigida in un referendum del 2021.[6] Altri casi evidenziano diverse difficoltà nel superare la sovranità nazionale: 2.1 L’unificazione sanitaria globale incontra ostacoli enormi, aggravati dal divario tra modelli pubblici e privati. Il sistema sanitario privatizzato degli Stati Uniti sta influenzando altre nazioni, rendendo la coordinazione globale ancora più complessa. Se un Paese può ritirarsi dall’OMS – come ha fatto Trump il 20 gennaio 2025 – come può essere garantita una governance sanitaria globale efficace?[7] 2.2 Bandire beni dannosi, come le armi, si scontra con la realtà geopolitica e gli interessi nazionali. Gli Stati Uniti, tra i maggiori produttori di armamenti al mondo, hanno una cultura delle armi profondamente radicata, rendendo quasi impossibile l’applicazione di restrizioni internazionali. 2.3 Far valere i diritti fondamentali in paesi con regimi autoritari rimane un’impresa titanica. Come possono tali diritti affermarsi in contesti come l’Afghanistan, in cui persino l’architettura è strumentalizzata e volta all’oppressione, come nel caso della rimozione delle finestre per nascondere le donne?[8] Queste problematiche richiamano la lungimirante riflessione di Alexandre Kojève in Esquisse d’une phénoménologie du Droit (1943, pubblicato nel 1981). Kojève sosteneva che il diritto internazionale, pur applicandosi agli Stati sovrani, è intrinsecamente limitato dalla sovranità nazionale stessa, creando un paradosso. Un vero diritto globale richiederebbe l’abolizione della sovranità nazionale, trasformando il diritto internazionale in diritto interno di una federazione globale. In questo modello, gli Stati conserverebbero l’autonomia ma non la sovranità, permettendo alla federazione di imporre obblighi giuridici ai suoi membri, proprio come uno Stato fa con i propri cittadini. Senza dubbio, la Costituzione della Terra proposta da Ferrajoli rappresenta un passo significativo in questa direzione. Tuttavia, continua a scontrarsi con contraddizioni strutturali: la tensione tra giurisdizione sovranazionale e sovranità nazionale rimane irrisolta.[10] Il cammino verso una governance globale richiede ancora una riflessione più profonda e soluzioni più concrete.
- Spezzare il Dominio dell’Economia e del Mercato sulla Politica – È possibile contenere il potere economico quando i mercati globali dettano le politiche nazionali e le multinazionali esercitano un’influenza schiacciante? Un caso emblematico è rappresentato dal precedente olandese del 2021, in cui, per la prima volta, una multinazionale è stata ritenuta responsabile della violazione dell’Accordo di Parigi. Tuttavia, nel 2024, la sentenza è stata annullata: la compagnia petrolifera Shell ha sostenuto che il verdetto fosse fondato su considerazioni politiche anziché giuridiche, dimostrando quanto il cammino verso una vera responsabilizzazione delle imprese sia ancora lungo.[11] Sul fronte di un sistema di tassazione globale, resta un interrogativo cruciale: se i sistemi fiscali nazionali faticano già a contrastare inefficienze ed evasione, come potrebbe riuscirci un quadro fiscale globale?
- Il Paradosso dei Diritti Individuali e delle loro Violazioni Invisibili – Ferrajoli mette in luce un paradosso fondamentale: i diritti individuali, da soli, potrebbero non essere sufficienti a proteggere l’ambiente dall’azione incontrollata delle forze economiche e politiche. La devastazione climatica non viene sempre percepita come una minaccia immediata alla salute o ai beni comuni, alimentando negazionismo, fatalismo o inazione politica. Eppure, la consapevolezza sta crescendo. Uno studio recente condotto su 75.000 persone in 77 Paesi rivela che l’80% degli intervistati è seriamente preoccupato per la crisi climatica, chiede un’azione governativa più incisiva e ha persino iniziato ad avviare azioni legali contro i governi per la loro inazione.[12]
Un Ideale Regolativo in Attesa di Essere Realizzato
Ferrajoli riconosce che il suo progetto si configura come un “ideale regolativo” kantiano – una visione di ciò che dovrebbe essere. Tuttavia, senza una strategia concreta per unire gli Stati-nazione contro il loro vero nemico comune, rischia di rimanere un’utopia. Quel nemico non è più un altro Stato, ma il tempo stesso – il ticchettio inarrestabile che scandisce gli ultimi istanti prima che il collasso ambientale diventi irreversibile. Senza un risveglio globale – un kantiano risveglio della ragione, capace di liberarci dall’ignoranza autoimposta e colpevole della nostra realtà – la metastasi descritta da Ferrajoli continuerà ad avanzare, fino a rendere impossibile qualsiasi cura futura.[13]
Il 2025 sarà un anno cruciale, poiché la Corte Internazionale di Giustizia emetterà un parere consultivo sulle responsabilità degli Stati nella lotta alla crisi climatica. Il caso, avviato nel 2024 su richiesta delle Nazioni Unite, pone due interrogativi fondamentali: quali obblighi giuridici hanno gli Stati, ai sensi del diritto internazionale, per ridurre le emissioni di gas serra e proteggere il pianeta? Quali sono le conseguenze legali delle loro azioni – o della loro inazione – nel causare danni significativi al sistema climatico?[14] Sebbene questo parere consultivo non imponga obblighi giuridici diretti agli Stati, avrà un peso politico e legale significativo. Contribuirà a plasmare il diritto internazionale, potrà guidare le decisioni delle Nazioni Unite e persino influenzare le legislazioni nazionali e le politiche interne. La Corte si trova di fronte a un equilibrio delicato: limitarsi a riaffermare principi già esistenti potrebbe avere un impatto marginale, mentre imporre mandati vincolanti rischierebbe di essere percepito come un’ingerenza giudiziaria eccessiva. Se «l’approccio più efficace per generare un impatto potrebbe essere quello di fornire quadri interpretativi chiari, lasciando alle istituzioni nazionali il compito di definirne le applicazioni specifiche»,[15] allora la proposta di Ferrajoli rappresenta già un passo avanti fondamentale – un passo che merita riconoscimento globale e un dibattito ancora più ampio.[16]
La Dr.ssa Giulia Battistoni è Presidente di SAFI-Societas Aperta Feminarum in Iuris Theoria. Attualmente è Marie Skłodowska-Curie Fellow presso l’Università di Verona e, negli ultimi due anni, ha lavorato alla Boston University e alla Friedrich-Schiller Universität Jena. Conduce una ricerca finanziata dall’Unione Europea su “Collective Responsibility Towards Nature and Future Generations”. I suoi interessi di ricerca si sono sempre concentrati sull’agire umano, sul tema della responsabilità e sull’imputazione, con particolare attenzione alla Filosofia Classica Tedesca (Hegel), all’etica della responsabilità di Hans Jonas e all’etica del discorso (Jürgen Habermas e Karl-Otto Apel). Attualmente sta approfondendo la biologia filosofica di Jonas e le filosofie della natura del Romanticismo e dell’Idealismo Tedesco per sviluppare una concezione della natura e dell’essere umano che offra una base per ripensarne il rapporto in modo fruttuoso e in chiave di etica ambientale.
La versione inglese di questo articolo è disponibile sul sito di SAFI: Parte 1; Parte 2.
Note:
[1] Questa sezione definisce la Terra come la “casa comune degli esseri viventi” (Art. 1), un pianeta vivente – in linea con il biocentrismo, l’ecocentrismo e il Weltorganismus romantico-idealista – una realtà dinamica che appartiene tanto alle generazioni presenti quanto a quelle future. L’umanità è considerata parte integrante della natura, la cui sopravvivenza è indissolubilmente legata al mondo naturale, sottolineando l’interdipendenza globale. In quanto “popolo della Terra”, gli esseri umani hanno una responsabilità collettiva nella preservazione della vita attraverso le generazioni. Questa visione, ispirata a Hans Jonas, solleva una questione fondamentale: le generazioni future dovrebbero avere una personalità giuridica? Il concetto di “Cittadinanza della Terra” (Art. 5) stabilisce uno status giuridico universale per tutti gli esseri umani. La guerra viene definita “massimo crimine contro l’umanità” (Art. 6), mentre la manipolazione genetica è consentita solo per scopi terapeutici e l’intelligenza artificiale non deve mai violare la dignità umana. Un “diritto alla disobbedienza” (Art. 24) consente di opporsi a ordini illeciti che implichino violenza o violazioni dei diritti. Il diritto alla salute è garantito attraverso l’accesso gratuito alle cure mediche essenziali (Art. 26). Infine, l’Articolo 54 vieta qualsiasi attività che causi danni ambientali irreversibili, alteri gli equilibri ecologici o distrugga la biodiversità.
[2] L’Articolo 59 stabilisce che: «La Federazione della Terra è aperta all’adesione di tutti gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e degli altri Stati esistenti» (enfasi aggiunta). Ciò solleva una questione cruciale: se la partecipazione è volontaria, la Federazione può davvero essere efficace? D’altro canto, renderla obbligatoria implicherebbe inevitabilmente una violazione della sovranità nazionale, mettendo in luce il delicato equilibrio del potere in gioco.
[3] Cfr. L. Ferrajoli, Per una Costituzione della Terra, p. 45.
[4] Negli ultimi anni, gli sforzi per ripensare il concetto di responsabilità in una prospettiva collettiva si sono moltiplicati, così come quelli volti a sviluppare un’idea di responsabilità globale e a esplorare il riconoscimento nuovi soggetti giuridici. Cfr., tra gli altri: B. Martin, L. Te Aho, M. Humphries-Kil (a cura di), ResponsAbility. Law and Governance for Living Well with the Earth, Routledge, Londra/NY 2019; S. Bazargan-Forward, D. Tollefsen (a cura di), The Routledge Handbook of Collective Responsibility, Routledge, Londra/NY 2020; T. Scavenius, Political Responsibility for Climate Change. Ethical Institutions and Fact-Sensitive Theory, Routledge, Londra/NY 2020; F.-C. Kring, Responsibility to Protect (2P) Revisited. Towards Climate Change-Related Obligations of States?, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlino 2020; A. Kumar Giri, The Calling of Global Responsibility. New Initiatives in Justice, Dialogues and Planetary Realizations, Routledge, Londra/NY 2023. Cfr. anche: IlPost.it.
[5] Cfr.: Environment.ec.europa.eu.
[6] Cfr.: Echr.coe.int; Eunews.it; Admin.ch.
[7] Cfr.: Reuters.com.
[8] Cfr.: TheIndependent.com.
[9] Cfr. la sezione dedicata al Diritto Internazionale in A. Kojève, Esquisse d’une phénoménologie du Droit, Gallimard 1982.
[10] Mi riferisco in particolare ai seguenti articoli: «La sovranità appartiene al popolo della Terra e a nessun altro. Nessun potere costituito può appropriarsene o usurparla» (Art. 33). L’Articolo 34 riconosce il diritto all’autodeterminazione dei popoli, sia interna che esterna, permettendo loro di scegliere liberamente il proprio sviluppo civile, politico, economico e culturale. Tuttavia, questo principio sembra difficilmente conciliabile con l’idea di sovranità sovranazionale. In caso di conflitto, l’autorità sovranazionale dovrebbe prevalere sulla sovranità nazionale, rischiando di compromettere democrazie e governi? Oppure la sovranità nazionale dovrebbe avere la priorità, mettendo a repentaglio gli obiettivi globali? La Costituzione della Terra suggerisce che l’autorità sovranazionale abbia la precedenza, come stabilisce l’Articolo 47: «Contro le violazioni dei diritti stabiliti da questa Costituzione, le persone e, mediante i loro rappresentanti, i popoli lesi, hanno diritto di ricorrere, in caso di mancata o denegata giustizia nei territori degli Stati, davanti alle giurisdizioni globali previste da questa Costituzione […]».
[11] Cfr.: Reuters.com; Internazionale.it.
[12] Cfr.: Internazionale.it.
[13] Esistono anche esempi positivi: nel settembre 2024, il Regno Unito ha chiuso la sua ultima centrale a carbone, un traguardo significativo considerando il ruolo storico di questa risorsa nello sviluppo economico britannico. Negli anni, il paese ha progressivamente sostituito il carbone con fonti rinnovabili. Cfr.: Internazionale.it. Nel frattempo, l’Australia ha approvato la costruzione della più grande centrale solare del mondo, capace di generare energia sufficiente per alimentare tre milioni di abitazioni. Cfr.: Internazionale.it.
[14] Cfr.: Internazionale.it.
[15] Cfr.: The Advisory Opinion Could Reshape Global Climate Governance, in Verfassungsblog.de.
[16] Per la stesura di questo testo, sono grata per le preziose discussioni e gli scambi avuti con colleghi/colleghe e amici/amiche – esperti/e in filosofia, diritto ed economia: Kristin Y. Albrecht, Gabriele Civello, Alma Diamond, Chiara Magni e Mattia Martini. Desidero inoltre ringraziare la Professoressa Chiara Ghidini e il Professor Giampiero Moretti dell’Università di Napoli l’Orientale, che, conoscendo i miei studi, mi hanno incoraggiata a confrontarmi attivamente con il notevole volume di Luigi Ferrajoli. This essay is part of the project Collective Responsibility towards Nature and Future Generations (ReNa), that has received funding from the European Union’s Horizon Europe Research and Innovation Programme under the Marie Skłodowska-Curie. Grant agreement No 101064728. Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency (REA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.