
Giulia Battistoni, Presidente di SAFI (Marie Skłodowska-Curie Global Fellow, Università di Verona)
Questa è la prima parte di una serie di due articoli sul blog, leggi la seconda parte qui.
Sull’Orlo dell’Apocalisse
Che il pianeta e l’umanità siano sull’orlo dell’Apocalisse è una realtà evidente a tutti.[1] Il conto alla rovescia verso la catastrofe ambientale è ormai agli sgoccioli. Non ci sono scuse per l’ignoranza colpevole – un concetto risalente ad Aristotele – secondo cui ignorare volontariamente informazioni accessibili a chiunque non fa che aumentare la responsabilità.[2] In un’era in cui abbiamo accesso a una quantità immensa di dati, scegliere di chiudere gli occhi di fronte alla realtà significa assumersi la responsabilità di conseguenze gravi e tangibili.
Nell’ultimo anno, disastri ambientali hanno colpito ogni angolo del pianeta, rendendo impossibile l’indifferenza. Gli incendi hanno devastato Los Angeles (2025) e la Grecia (2024), causando evacuazioni di massa e numerose vittime.[3] Le inondazioni hanno seminato distruzione su scala globale: Nepal, Bangladesh e Thailandia sono stati colpiti nell’estate del 2024;[4] a maggio 2024, violente alluvioni nel Rio Grande do Sul, in Brasile, hanno provocato morti e dispersi; ad aprile, le cosiddette “inondazioni del secolo” in Cina hanno costretto oltre 50.000 persone ad abbandonare le proprie case. Anche l’Europa non è stata risparmiata: Spagna, Germania e Italia hanno affrontato gravi emergenze idrogeologiche nello stesso periodo.[5] Le ondate di calore si sono rivelate ancora più letali. Le temperature hanno superato i 40°C nel Mediterraneo e hanno raggiunto i 62°C a Rio de Janeiro.[6] A febbraio 2024, il presidente della Catalogna ha dichiarato lo stato di emergenza a Barcellona per una siccità senza precedenti, mentre a maggio un tribunale indiano ha sollecitato il governo a fare lo stesso in risposta a un’ondata di calore mortale.[7] Nell’estate del 2024, oltre 1.300 fedeli sono morti durante il pellegrinaggio alla Mecca a causa delle temperature estreme.[8] Le Nazioni Unite hanno classificato questa crisi come un’epidemia di calore estremo.[9] Tutto questo è il risultato del rapido peggioramento della della crisi climatica: il 2024 è stato il primo anno a superare la soglia di 1,5°C, rendendo sempre più irraggiungibile l’obiettivo di contenere il riscaldamento globale al di sotto dei 2°C – e idealmente sotto 1,5°C.[10] Il consumo di carbone è in aumento, soprattutto in India e Cina, con conseguente incremento delle emissioni di anidride carbonica e metano, mentre la deforestazione in Indonesia e in Amazzonia – guidata dall’estrazione mineraria e dall’agricoltura – sta ulteriormente indebolendo la capacità del pianeta di assorbire i gas serra.[11]
Nonostante l’urgenza, i progressi sono stati minimi. La crisi rivela un vuoto politico e normativo, che rende sempre più evidente la necessità di istituzioni sovranazionali efficaci per affrontare queste minacce di questa portata.
Dalla Crisi al Cambiamento: un’Iniziativa Italiana Nata durante la Pandemia
La pandemia di COVID-19 ha messo in luce le carenze delle istituzioni sovranazionali nella gestione delle crisi globali e le difficoltà dei governi nazionali nel coordinare interventi tempestivi ed efficaci. Ha inoltre rafforzato la consapevolezza della vulnerabilità umana e del legame inscindibile tra il benessere delle persone e la salute del pianeta.[12]
Non è un caso, quindi, che proprio durante la pandemia sia nato un progetto significativo per una Costituzione della Terra.
Il 21 febbraio 2020, un’illustre assemblea di giuristi, politici, economisti e filosofi si è riunita a Roma per promuovere l’adozione di obblighi vincolanti in materia di tutela dei diritti umani.[13] Tra le figure chiave vi era il giurista italiano Luigi Ferrajoli, che ha successivamente approfondito ed elaborato queste idee nel suo libro Per una Costituzione della Terra (2022). In quest’opera, Ferrajoli sostiene la necessità di sviluppare un quadro giuridico globale fondato su principi costituzionali universali per affrontare le crisi più urgenti, a partire dall’emergenza ecologica. Radicata nel pensiero kantiano, la sua visione concepisce l’umanità come un’unica società globale, bisognosa di un ordine cosmopolitico: una federazione dei popoli per scongiurare l’autodistruzione. Per quanto possa apparire, prima facie, utopico, Ferrajoli sostiene la necessità di elevare il costituzionalismo a livello sovranazionale, ritenendolo non solo auspicabile, ma persino inevitabile.[14] Questo articolo si propone di analizzare criticamente la sua proposta.
La prima parte del libro affronta il tema delle catastrofi globali. Secondo Ferrajoli, la pandemia di COVID-19 ha confermato l’universalità del diritto alla vita e alla salute, mettendo in luce due gravi falle del sistema: 1. un sistema sanitario frammentato, incapace di garantire un accesso universale alle cure; 2. istituzioni deboli, come l’OMS, prive di strumenti vincolanti per far rispettare i diritti fondamentali. Con governi che hanno agito in modo indipendente – spesso privilegiando gli interessi del mercato – la pandemia ha evidenziato la necessità di una governance globale più coordinata. Di fronte a cinque emergenze globali – crisi climatica, guerre nucleari, violazioni dei diritti fondamentali, sfruttamento del lavoro e migrazioni di massa – Ferrajoli propone l’istituzione di garanzie giuridiche sovranazionali per limitare il potere degli Stati e dei mercati ed espandere il costituzionalismo su scala planetaria.[15]
Ferrajoli descrive la crisi ambientale con un’immagine tanto cruda quanto potente: una “metastasi che sta divorando il pianeta”, un tumore mortale in crescita incontrollata che minaccia la sopravvivenza stessa della Terra. Egli attribuisce all’umanità e ai suoi leader una “colpa imperdonabile”, respingendo qualsiasi pretesa di ignoranza come scusa. Al centro della sua analisi vi è il concetto di crimini di sistema: reati talmente vasti da sfuggire alle categorie tradizionali del diritto penale. Privi di autori chiaramente individuabili e spesso coinvolgendo intere popolazioni o l’umanità stessa, questi crimini mettono in discussione il principio di responsabilità individuale e rivelano le lacune del sistema giuridico attuale. Questa riflessione solleva interrogativi cruciali sulla responsabilità e sui limiti del diritto. Il diritto penale classico si basa sul principio Nullum crimen, nulla poena sine lege – nessun crimine e nessuna pena senza una norma giuridica che li definisca. In altre parole, senza una disposizione legale, un atto non può essere considerato reato né punito penalmente. Inoltre, ogni crimine richiede due elementi: l’actus reus (l’azione illecita) e la mens rea (l’intenzione o la consapevolezza del danno). Tuttavia, i danni ambientali sfuggono a questa logica: il loro impatto si manifesta nel tempo, la causalità è complessa da dimostrare e chi inquina lo fa spesso per profitto, senza una diretta intenzione. Tutti questi fattori complicano l’inquadramento giuridico dei danni ambientali, sebbene possano essere perseguiti per negligenza o mancata diligenza. Ferrajoli sostiene, dunque, a ragione che i crimini ambientali costituiscono violazioni dei diritti fondamentali che – almeno per il momento, aggiungerei io – sfuggono alla portata del diritto penale tradizionale.[16]
Le devastazioni ambientali continuano, pertanto, a costituire violazioni di diritti costituzionali, sia a livello nazionale che sovranazionale, senza un chiaro quadro giuridico di riferimento.[17] Per colmare questa lacuna normativa, Ferrajoli propone di ricollocare la responsabilità dal diritto penale alla sfera politica. A suo avviso, limitare il concetto di “crimine” ai soli reati previsti dalla legge penale genera una “indignazione selettiva”, permettendo che danni su larga scala passino inosservati o vengano normalizzati. Con l’introduzione della categoria dei crimini di sistema – gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani che dovrebbero ricadere sotto la responsabilità politica – Ferrajoli evidenzia il potere performativo – io direi persino trasformativo – del linguaggio giuridico nel modellare la percezione pubblica e l’azione legale. L’idea è che, una volta affermati questi concetti, potranno – e dovranno – essere istituite giurisdizioni internazionali volte ad indagare, giudicare e applicare sanzioni efficaci.
La seconda parte dell’opera di Ferrajoli analizza i limiti del costituzionalismo odierno, mettendo a confronto due modelli: 1. il modello nazionalista, ispirato alla concezione schmittiana dello Stato come entità omogenea e unitaria, che si nutre della dinamica amico-nemico, alimentando conflitto e guerra;[18] 2. il modello pluralista, che limita tutti i poteri per tutelare i diritti fondamentali, promuove la diversità politica e incoraggia la convivenza pacifica basata su solidarietà e sul dialogo. Ferrajoli sostiene che gli Stati-nazione sovrani siano incapaci di affrontare le sfide globali, poiché restano ancorati al primo modello, rafforzando divisione e competizione. L’unica soluzione, a suo avviso, è adottare il secondo modello su scala sovranazionale. Inoltre, il costituzionalismo globale dovrebbe risolvere contraddizioni fondamentali, come quella tra diritti universali e cittadinanza limitata, o tra pace e sovranità statale, quest’ultima responsabile di perpetuare la legge del più forte.[19] In questo quadro, anche i concetti di cittadinanza e sovranità devono essere ridefiniti, poiché l’idea tradizionale di sovranità non farà altro che perpetuare il conflitto a livello internazionale – una dinamica già riconosciuta da Hegel.[20]
Ferrajoli attribuisce il fallimento dei sistemi costituzionali nazionali alla natura intrinsecamente a breve termine della democrazia, focalizzata sugli interessi nazionali e incapace di favorire un’azione globale efficace. A suo avviso, nessuno Stato intraprenderà riforme ecologiche significative senza una strategia globale coordinata. Poiché gli Stati-nazione restano attori locali condizionati dai mercati globali, la politica è ormai subordinata all’economia, rendendo il costituzionalismo nazionale inefficace. Anche la democrazia necessita, secondo Ferrajoli, di una ridefinizione. Sebbene gli accordi internazionali dichiarino di proteggere le libertà, senza efficaci meccanismi di applicazione i diritti fondamentali rimangono privi di tutela. Anche le Nazioni Unite risultano indebolite da garanzie giuridiche insufficienti per i diritti umani e da un’enfasi eccessiva sulla sovranità nazionale, che ostacola una reale governance sovranazionale. Emblematico è il caso della Corte Penale Internazionale del 1998, privo di sostegno delle maggiori potenze.[21] Il problema di fondo è la dipendenza del diritto internazionale dagli Stati-nazione. Sebbene la Carta dell’ONU fornisca una base per la governance globale, essa non dispone del potere di prevalere sulla sovranità statale. Per realizzare una Federazione della Terra, Ferrajoli propone la creazione di istituzioni globali capaci di far rispettare leggi, diritti, uguaglianza, pace e tutela delle risorse.[22] La sua soluzione: un sistema duale di garanzie giuridiche per colmare le lacune del diritto internazionale:
-
Garanzie primarie, garantite da istituzioni che prevengono i danni e assicurano l’accesso ai diritti fondamentali, come la libertà, l’uguaglianza e la non discriminazione. Ciò include il rafforzamento dell’OMS e della FAO, la creazione di un sistema di beni comuni globali per risorse essenziali come l’acqua e la trasformazione di istituzioni come la Banca Mondiale in entità indipendenti, libere dall’influenza delle nazioni più ricche.
-
Garanzie secondarie, attuate attraverso meccanismi giudiziari per affrontare le violazioni dei diritti primari, tra cui una Corte Costituzionale Globale e una giurisdizione per i crimini di sistema. Ferrajoli propone, inoltre, un sistema di tassazione globale per impedire lo sfruttamento dei beni comuni globali da parte delle nazioni più ricche, che attualmente li trattano come res nullius (proprietà senza padrone).[23]
Nella terza parte del suo volume, Ferrajoli amplia la prospettiva del costituzionalismo al di là dello Stato, delineando tre quadri concettuali fondamentali: 1. costituzionalismo sovrastatale, volto a garantire la pace internazionale, dichiarare la guerra un crimine, abolire gli eserciti nazionali e assicurare la tutela sovranazionale dei diritti fondamentali;[24] 2. costituzionalismo dei mercati, finalizzato a limitare il predominio del mercato, impedire il dominio del mercato sulla politica e restituire dignità al lavoro attraverso un controllo normativo efficace;[25] 3. costituzionalismo dei beni comuni, volto a proteggere le risorse essenziali – sia naturali (come aria e acqua) sia artificiali (come farmaci) – riconoscendole come beni comuni globali, vietandone la mercificazione e introducendo garanzie dirette contro la proliferazione di armi e le emissioni di gas serra.[26]
Continua a leggere la seconda parte dell’articolo.
Note:
[1] Il 28 gennaio 2025, l’Orologio dell’Apocalisse, creato nel 1947 da un gruppo di scienziati per offrire un’immagine simbolica della minaccia esistenziale che incombe sull’umanità, è stato spostato un secondo più vicino alla mezzanotte, segnalando l’aggravarsi delle crisi globali. Cfr.: TheBulletin.org.
[2] Questo è paragonabile a un individuo che provoca un incidente mentre è in stato di ebbrezza: la sua negligenza è il fattore determinante. Si tratta della distinzione fondamentale tra “agire ignorando” (quando si sceglie di ignorare una conoscenza disponibile, rendendo l’ignoranza colpevole) e “agire per ignoranza” (quando si è realmente all’oscuro di una situazione e non si poteva conoscerne le circostanze o le conseguenze). Nel primo caso, si è responsabili; nel secondo, si è scusati dalla colpa. Cfr.: G. Battistoni, Azione e imputazione in G.W.F. Hegel alla luce dell’interpretazione di K.L. Michelet, IISF Press, Napoli 2020, p. 121 ss., e Aristotele, Etica Nicomachea, III, 2, 1110 b 25-1111 a.
[3] Cfr.: TheGuardian.com. Sebbene alcune regioni siano da sempre esposte a tali eventi, i cambiamenti climatici ne hanno intensificato gli effetti.
[4] Cfr.: Reuters.com; Reuters.com; Reuters.com.
[5] Tra il 2014 e il 2023, il numero di regioni del mondo esposte a precipitazioni torrenziali è aumentato di oltre il 50% rispetto al periodo 1961-1990. Cfr.: TheGuardian.com; Reuters.com; ElPais.com; Spiegel.de; Repubblica.it; Internazionale.it.
[6] Cfr.: Internazionale.it.
[7] Cfr.: Internazionale.it; Internazionale.it.
[8] Nell’agosto 2021, la Sicilia ha registrato un record europeo di 48,8°C. Cfr.: Internazionale.it. Alla Mecca, molti decessi sono stati attribuiti a un “pellegrinaggio non autorizzato”, che ha lasciato centinaia di persone senza riparo climatizzato. Cfr.: TheGuardian.com; Internazionale.it.
[9] Cfr.: Wmo.int.
[10] Cfr.: Internazionale.it.
[11] Cfr.: LeMonde.fr; Internazionale.it; TheGuardian.com. L’Amazzonia, essenziale per mitigare i cambiamenti climatici, ha già perso un’area equivalente alla somma di Francia e Germania. Tuttavia, sono in corso iniziative per contrastare la deforestazione. Cfr.: TheGuardian.com.
[12] Cfr.: G. Battistoni, A biocentric ontology at the basis of an anthropocentric concept of co-responsibility to non-human world, in «Filosofia Morale/Moral Philosophy» 2/2023, 4, pp. 101-110 (Open Access).
[13] Tra i partecipanti: Raniero La Valle, Luigi Ferrajoli, Valerio Onida, il vescovo Nogaro, Riccardo Petrella e altri. Cfr.: IlManifesto.it; IlManifesto.it.
[14] Cfr. L. Ferrajoli, Per una Costituzione della Terra. L’umanità al bivio, Feltrinelli, Milano 2022, p. 18.
[15] Ivi, p. 28. Le citazioni da questo volume sono di mia traduzione.
[16] Affrontarle in questo contesto richiederebbe probabilmente una revisione di concetti chiave come responsabilità e imputazione, oltre al riconoscimento dell’ecocidio nel diritto penale internazionale – un processo già avviato, considerando che alcuni paesi hanno iniziato a classificare i danni ambientali gravi come reati nelle loro legislazioni nazionali. Cfr.: Linkiesta.it; TheGuardian.com. Inoltre, il concetto di responsabilità, tradizionalmente di carattere retrospettivo e individuale, deve essere ripensato in una prospettiva collettiva e orientata al futuro – un dovere etico prima ancora che giuridico, basato sulla cura dell’ambiente e delle generazioni future. Ho sviluppato queste idee in: G. Battistoni, Per una fondazione razionale della co-responsabilità verso la natura e le generazioni future, in «Pòlemos. Materiali di filosofia e critica sociale» 1, 2023, pp. 101-120 (Open Access), e G. Battistoni, A biocentric ontology at the basis of an anthropocentric concept of co-responsibility to non-human world, in «Filosofia Morale/Moral Philosophy» 2/2023, 4, pp. 101-110. Cfr. anche: M. Calloni, Human Development and Sustainability. Towards a Multilayered Idea of Co-Responsibility, in «Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie», vol. 110, issue 4 (a cura di K. Y. Albrecht/G. Battistoni/S. Zucca-Soest), 2024, pp. 504-518.
[17] Cfr. L. Ferrajoli, Per una Costituzione della Terra, p. 41.
[18] «Das Wort „Verfassung“ muß auf die Verfassung des Staates, d. h. der politischen Einheit eines Volkes beschränkt werden […]». C. Schmitt, Verfassungslehre, Duncker&Humblot, Berlino 2017 [1ª ed. 1928], p. 3.
[19] Cfr. L. Ferrajoli, Per una Costituzione della Terra, p. 59.
[20] Cfr. G.W.F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, a cura di G. Marini, Laterza, Roma-Bari 2010, §§ 333-334. Cfr. anche L. Ferrajoli, Per una Costituzione della Terra, p. 60.
[21] Ivi, p. 66; pp. 75-76.
[22] Ivi, p. 79.
[23] Ivi, p. 83 ss.
[24] Vedi cap. 9.
[25] Vedi cap. 10.
[26] Vedi cap. 11.
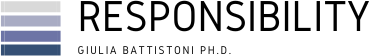


1 Comment. Leave new
La relazione, attraverso un’esposizione chiara e rigorosa, affronta tematiche interessanti, anche per la loro attualità. Tanti gli spunti di riflessione e dibattito sia per chi è specialista della materia come per chi non lo fosse. Ho trovato particolarmente utile il riferimento ad autori che intendo approfondire.